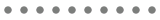
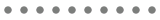
| come sfogliare le pagine | utilizzo dei bottoni | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
indice
Nell'inviare il materiale (scritti, racconti, storie, fotografie, produzioni multimediali e ricerche, etc.) accetto e riconosco quanto sotto riportato:
ai sensi e per gli effetti di legge e con particolare riferimento alla Legge 633/1941 e successive variazioni ed integrazioni in materia di diritto d'autore, l'uso, la riproduzione e la pubblicazione sul sito www.martignaccospazioaperto.it avverrà a fini divulgativi e promozionali.Detta autorizzazione deve intendersi inclusiva di ogni facoltà di modifica e integrazione, fermo restando che, comunque ogni modifica dovrà essere preventivamente approvata dall'Autore e non dovrà mai comportare la lesione della dignità personale e del decoro.La predetta pubblicazione costituisce una facoltà e non un obbligo a carico di martignaccospazioaperto, che non garantisce né si assume responsabilità circa l'esattezza, la competenza e, in generale, il contenuto del materiale inviato dai collaboratori.
Dichiaro di essere maggiorenne;
Di essere consapevole che mediante l'invio del materiale mi impegno a concedere a martignaccospazioaperto il diritto e la licenza di riprodurre quanto inviato, per intero o per una parte di essi .
Che l'utilizzo e/o licenza nei suddetti termini non daranno luogo ad alcun compenso in capo all'autore essendo ogni relativa pretesa soddisfatta dall'interesse a vedere pubblicato il proprio contributo sul sito www.martignaccospazioaperto, abbinato al proprio nome quale autore dello stesso.
Garantisco che l'Autore è titolare dei relativi diritti d'autore e che niente di quanto inviato è contrario a norme imperative di legge, ordine pubblico e buon costume e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche;
Garantisco di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la diffusione degli stessi da tutte le persone e gli enti coinvolti, e che pertanto la relativa riproduzione da parte di martignaccospazioaperto non comporterà la violazione di legge o dei diritti di terzi;
Dichiaro di essere consapevole che la responsabilità del contenuto del materiale è a carico della persona che li ha inviati;
Dichiaro di essere consapevole che martignaccospazioaperto non ha alcun potere di controllo e di vigilanza su quanto inviato e che pertanto la stessa non assume alcun onere di protezione con riferimento all'utilizzo anche abusivo di terze parti;
a) Con l'invio del materiale accetto tutto quanto sopra detto ed esprimo il piú ampio consenso alla riproduzione nelle pagine del sito www.martignaccospazioaperto
b) Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs.196/2003).
c) Accetto che il materiale inviato sia conservato in collezioni già presenti nella Biblioteca Civica "Elsa Bujese", per una piú idonea e certa conservazione.
| titolo | |
|
| |